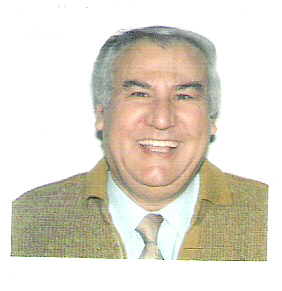Per comprendere la politica
Il pensiero stesso di poter «riverberare» - ahi me - la mia tanta «esperienza», infervora quel volersi sentire ancora attivo. Una riflessione sulla conoscenza tacita: considera l’esperienza, ma anche la difficoltà di esplicitazione. Quel fervore e questa difficoltà m’inducono a partecipare, e imparare, a costruire una nuova conoscenza. È un dato di fatto: il sapere di «milioni d’intelligenze umane» è sempre al lavoro, si smaterializza passando dal testo stampato alla rete, si amplifica per la sua caratteristica di editabilità, si distribuisce di computer in computer attraverso le linee telefoniche. Si è ormai in tanti nel sostenere che «impareremo a costruire una conoscenza nuova, non totalitaria, dove la libertà di navigazione, di scrittura, di lettura e di selezione dell’individuo o del piccolo gruppo sarà fondamenta della conoscenza, dove per creare un nostro punto di vista, un nostro sapere, avremo bisogno inevitabilmente della conoscenza dell’altro, dove il singolo sarà, liberamente e consapevolmente parte di un tutto».
Per comprendere la politica bisogna partire dalla concezione che si ha dell’anima e dell’uomo. Per Platone «l’anima è la parte pura dell’uomo, il corpo è quella torbida. L’anima è in sommo grado a ciò che è divino (…) mentre il corpo è in sommo grado a ciò che è umano (…) e mai identico a se medesimo». I mali dell’uomo sono dovuti principalmente al corpo e ai suoi desideri irrefrenabili. E anche questo è un dato di fatto inconfutabile. I politici non amministrano lo Stato, ma si focalizzano sul parlare, promettere... l'amministrazione diretta la fanno altri. La fanno i membri delle burocrazie, che spesso sono imparentati con la politica. Volendo si può continuare a lungo, nella tediosa maniera sempre meno efficace. M’intriga la sollecitazione per un’analisi del pensiero politico non strumentalizzato, ma semplicemente letto e studiato con spunti di riflessioni attuali, preoccupandosi di scartare certi eccessi polemici. La casualità di alcune mie letture a proposito mi porta, intanto, a soffermarmi su uno dei pensieri politici più lucidi e, a mio vedere, attuali, del secolo appena trascorso: ne inserisco alcuni paragrafi.
E' opinione diffusa che siano esistiti due Sturzo, uno «di sinistra» nel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, e uno «di destra» nell'immediato dopoguerra. Ma è vero solo in parte. Il primo Sturzo, quello della nascita del Partito Popolare, non era poi così lontano dal secondo, quello della guerra fredda. Era un prete coraggioso, impegnato nel sociale, capace di interpretare al meglio quelle che erano le esigenze della società italiana in quel periodo. Ma non elaborò mai un pensiero realmente di sinistra così come non si schierò mai in modo esplicito per l'interventismo dello stato nell'economia.
In esilio per vent'anni, con l'esperienza americana che lo colpì in modo decisivo (vi visse sei anni), lo Sturzo che ritornò in Italia nel dopoguerra era un convinto liberale e liberista, tanto da guadagnarsi gli elogi sperticati e la nomina a senatore a vita del padre del liberalismo italiano, il Presidente Luigi Einaudi. La "conversione" liberista di Sturzo non fu frutto solo del viaggio in America e della "scoperta" di una realtà completamente nuova e tutta improntata alle regole della democrazia liberale e a quelle del mercato. Il fondatore del Partito Popolare, tenace anti-comunista sia per ragioni morali e religiose che per ragioni economiche, capì che ora non era più il fascismo, ormai sconfitto, a rappresentare il pericolo per la democrazia, ma il dirigismo e lo statalismo esasperato della sinistra, anche quella cattolica. La polemica sturziana, oltreché contro il comunismo, fu, infatti, diretta contro i fautori di quella che sarebbe stata la svolta del centro-sinistra e in questa polemica si trovò avversario anche di De Gasperi.
Sturzo affrontò la questione non da economista, quale non era, ma da politico. Nell'eccessivo intervento dello Stato nell'economia intravedeva, prima di tutti, non tanto l’inefficienza dal punto di vista economico, ma i pericoli per l'esplosione di una ventata di corruzione legata alla spartizione dei posti nelle aziende pubbliche che di lì a poco, con Enrico Mattei, avrebbe infettato tutto il mondo politico italiano, fino al cancro di Tangentopoli. In chiave anti-comunista don Sturzo propose addirittura un'apertura alla destra missina, convinto che il centro-destra avesse in comune quei valori nazionali e spirituali che il comunismo negava.
La sua avversione per il comunismo derivava, infatti, in massima parte da considerazioni morali e dalla convinzione che il collante della nazione italiana fosse dato soprattutto dalla religione cattolica, che il comunismo negava. Con l'apertura alla destra Sturzo avrebbe consolidato uno dei due poli, collocandolo definitivamente su posizioni decisamente liberali e liberiste, senza rendere né necessario né auspicabile un'alleanza "innaturale" come quella del centro-sinistra. Dal punto di vista di un bipolarismo consolidato che tagliasse fuori i comunisti Sturzo, sperava innanzitutto che il Partito Socialista si affrancasse dall'abbraccio mortale del Partito Comunista, venendo a formare un polo di sinistra che avversava ma che sarebbe comunque rimasto nell'alveo della democrazia. Ma non avvenne nulla di tutto questo. La legge elettorale che avrebbe potuto facilitare la formazione di un bipolarismo (la cosiddetta "legge truffa") fu bocciata. Il Partito Socialista rimase appiattito sulle posizioni del Pci, per poi scardinare il possibile bipolarismo alleandosi con la Dc, mentre a destra non si formò mai quell'alleanza vagheggiata da Sturzo. Fu proprio la Dc a tradire le speranze del prete di Caltagirone con la svolta del centro-sinistra, che Sturzo avversò con tutte le sue forze.